Sono certa che la paura sia catartica. Le fiabe lo dimostrano da sempre: nate nella notte dei tempi, passate di bocca in bocca fino ad essere suggellate dalla parola scritta, usano i simboli per parlare direttamente all’inconscio. Noi non abbiamo bisogno di capire, la parte più ancestrale che portiamo dentro riceve i messaggi forti e chiari su temi importanti, universali, che riguardano ognuno di noi da sempre.
La paura nei racconti per l’infanzia
Un linguaggio così espresso non può che essere accolto al volo dai bambini. Ciò che li spaventa davvero è rappresentato dalle cose che non capiscono, quelle che magari nessun adulto spiega loro. L’ignoto e il non detto rischiano di diventare tabù, di ingigantirsi e trasformarsi in veri pericoli. Le paure sbiadiscono ogni volta che vengono affrontate e non c’è niente di più sicuro che farlo all’interno di una storia. Ciò che angoscia, allo stesso tempo incuriosisce: i bambini sono piccoli ricercatori della vita, studiano e analizzano tutto quello che viene loro offerto, ma un posto d’onore lo hanno le emozioni. Talvolta si presentano ingombranti e ingestibili; affrontarle è l’obbligo morale del genitore il quale non può essere una figura onnisciente che sempre sa cosa fare, ma disponibile ad accompagnare anche nella notte più scura, quella del cuore.
IT: metafora della letteratura horror
 Avere paura ci serve. Per l’uomo primitivo era la salvezza nelle situazioni di pericolo: reagisci e attacca, oppure scappa. Nella fiction cinematografica e letteraria non possiamo fuggire e non possiamo attaccare: la paura può soltanto essere vissuta. La storia narrata si trasforma in un confronto con noi stessi, perché qualsiasi narrazione buona ha qualcosa da dirci. Gli spietati assassini raccontati diventano i nostri killer personali, quelli che ci seguono giorno dopo giorno e che non sappiamo mai come affrontare. Ciò che leggiamo assume la forma di ciò che temiamo nel nostro intimo: vediamo questo processo nel famoso romanzo “It” di Stephen King. Il terribile pagliaccio non solo spaventa in quanto mostruoso, pericoloso e soprannaturale, ma ha la peculiarità di mostrare ad ogni malcapitato i suoi terrori nascosti. I quali spesso sono la nostra ombra sin dai tempi della nostra infanzia. Come da Pennywise, fuggire è inutile perché non si tratta più del lupo con cui si trovava faccia a faccia il nostro antenato. La sola strada è accogliere lo scontro finale. Scappa, o attacca.
Avere paura ci serve. Per l’uomo primitivo era la salvezza nelle situazioni di pericolo: reagisci e attacca, oppure scappa. Nella fiction cinematografica e letteraria non possiamo fuggire e non possiamo attaccare: la paura può soltanto essere vissuta. La storia narrata si trasforma in un confronto con noi stessi, perché qualsiasi narrazione buona ha qualcosa da dirci. Gli spietati assassini raccontati diventano i nostri killer personali, quelli che ci seguono giorno dopo giorno e che non sappiamo mai come affrontare. Ciò che leggiamo assume la forma di ciò che temiamo nel nostro intimo: vediamo questo processo nel famoso romanzo “It” di Stephen King. Il terribile pagliaccio non solo spaventa in quanto mostruoso, pericoloso e soprannaturale, ma ha la peculiarità di mostrare ad ogni malcapitato i suoi terrori nascosti. I quali spesso sono la nostra ombra sin dai tempi della nostra infanzia. Come da Pennywise, fuggire è inutile perché non si tratta più del lupo con cui si trovava faccia a faccia il nostro antenato. La sola strada è accogliere lo scontro finale. Scappa, o attacca.
Rosemary’s baby: il male dentro di noi
 Nel romanzo “Rosemary’s baby”, Ira Levin ci racconta l’amara eventualità in cui il male da combattere si trovi dentro di noi. In questo caso, l’interiorizzazione ha raggiunto il suo massimo livello. Sin dall’inizio del romanzo c’è la percezione della presenza di un male potente e sconosciuto, ma non si è capaci di localizzarlo, né di dargli un nome. Purtroppo per la protagonista, esso si è annidato laddove non è possibile estirparlo. L’angoscia del lettore sale capitolo dopo capitolo, mentre tutto diventa più chiaro e si avverano i peggiori sospetti. La paura è grande, ma scompare in un solo istante dal momento che il peggio viene accettato. Scendere a patti con il proprio terrore, infine, è proprio questo: guardarlo con franchezza ed accettarlo come tale, considerando in maniera inedita che lo scontro finale non è più così necessario, quanto scendere a patti.
Nel romanzo “Rosemary’s baby”, Ira Levin ci racconta l’amara eventualità in cui il male da combattere si trovi dentro di noi. In questo caso, l’interiorizzazione ha raggiunto il suo massimo livello. Sin dall’inizio del romanzo c’è la percezione della presenza di un male potente e sconosciuto, ma non si è capaci di localizzarlo, né di dargli un nome. Purtroppo per la protagonista, esso si è annidato laddove non è possibile estirparlo. L’angoscia del lettore sale capitolo dopo capitolo, mentre tutto diventa più chiaro e si avverano i peggiori sospetti. La paura è grande, ma scompare in un solo istante dal momento che il peggio viene accettato. Scendere a patti con il proprio terrore, infine, è proprio questo: guardarlo con franchezza ed accettarlo come tale, considerando in maniera inedita che lo scontro finale non è più così necessario, quanto scendere a patti.
Dracula: perdere l’energia vitale

In “Dracula” di Bram Stocker il rischio in gioco del rapportarsi con la paura è la perdita della propria energia vitale. Il vampiro succhia via la vita morso dopo morso, lasciando un cadavere capace di uccidere e seminare infelicità e dolore a sua volta. Parafrasi della depressione, vengono uniti il timore di perdere se stessi a quello di perdere l’altro: peggio della morte, c’è soltanto l’entrata in una sorta di mondo parallelo, una vita vissuta ai margini della società, nascosti nell’ombra, capaci di nutrirsi solo di dolore e morte. L’autore però ci lascia una speranza: il giorno torna sempre e con esso si chiudono le bare. I non morti grazie alla luce del sole possono essere definitivamente eliminati.
Edgar Alla Poe e Guy de Moupassant
 La paura più grande è quella che rimane inafferrabile, indefinita. E’ quella che non riesce mai ad avere un volto. In racconti come “Il gatto nero” di E.A. Poe e “Le Horla” di G. De Moupassant, è difficile definire chi rappresenti davvero il male, presente e strisciante in ogni pagina ma così sfuggente. Si annida nel protagonista? Si nasconde in casa? È un’entità sovrannaturale? O è soltanto immaginato? Non riceviamo risposte certe, ed era quello che temevamo di più: questi maestri della suspance ci accompagnano per mano in mondi inquietanti dove dimora il dubbio, per poi abbandonarci, da soli con le nostre domande, in un indefinito finale a sorpresa. Non ci concedono consolazioni.
La paura più grande è quella che rimane inafferrabile, indefinita. E’ quella che non riesce mai ad avere un volto. In racconti come “Il gatto nero” di E.A. Poe e “Le Horla” di G. De Moupassant, è difficile definire chi rappresenti davvero il male, presente e strisciante in ogni pagina ma così sfuggente. Si annida nel protagonista? Si nasconde in casa? È un’entità sovrannaturale? O è soltanto immaginato? Non riceviamo risposte certe, ed era quello che temevamo di più: questi maestri della suspance ci accompagnano per mano in mondi inquietanti dove dimora il dubbio, per poi abbandonarci, da soli con le nostre domande, in un indefinito finale a sorpresa. Non ci concedono consolazioni.
Il coraggio di osservare
La paura è catartica: racchiusa nella gabbia del romanzo, ci permette di guardarla in faccia senza essere pericolosa e senza farci troppo male. Spenta la tv, chiuso il libro, torniamo al sicuro portando con noi solo un po’ di batticuore.
I mostri gettano la luce sull’inconscio: attrezzano il soggetto a vivere con le proprie ombre. Non è possibile cancellarle, dannoso è nasconderle. Per questo le storie di paura, per tutte le età, non producono una reale angoscia bensì rassicurazione. Concentrarsi sulla storia di un altro, che magari ricorda la propria, distrae la mente dalle ansie, dà un volto ai pensieri… e tutto ciò che ha un volto è molto meno orrorifico di quello che rimane nascosto dietro un cappuccio.



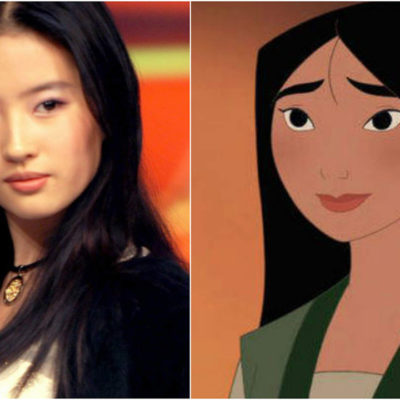






Lascia un commento